Le città italiane avevano atteso tante volte la discesa imperiale e sempre, dopo ogni discesa, si erano ritrovate in mezzo alle guerre, alla fame, alla peste.
di Patrizia Danzè
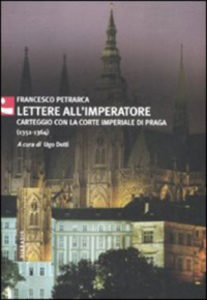 Francesco Petrarca – Lettere all’imperatore In nessuna biografia si è scandagliato forse con più accanimento quanto in quella del Petrarca, per cercarvi e scoprirvi, tra le altre cose, i movimenti politici interiori -forse appena sussulti- anche quelli semplicemente emotivi, o solamente occasionali. Di un Petrarca “impolitico” (un giudizio piuttosto ambiguo, se non oscuro) si è sentito più volte ripetere, soprattutto sui banchi di scuola, magari perché si apprezzassero maggiormente i furori civili di Dante, furori dai quali Petrarca si sarebbe liberato, distaccandosi così dalla politica attiva e militante, cui avrebbe preferito ora le corti ora la campagna, ora l’otium letterario ora la società dei dotti. Fu ingeneroso il Risorgimento letterario italiano verso il nostro grande Petrarca, come lo fu tutta la critica romantica, “colpevole” di averci offerto su un piatto pregiudizievole un Petrarca privo di quella coscienza dell’unità politica dell’Italia che l’amor di patria romantico esigeva .
Francesco Petrarca – Lettere all’imperatore In nessuna biografia si è scandagliato forse con più accanimento quanto in quella del Petrarca, per cercarvi e scoprirvi, tra le altre cose, i movimenti politici interiori -forse appena sussulti- anche quelli semplicemente emotivi, o solamente occasionali. Di un Petrarca “impolitico” (un giudizio piuttosto ambiguo, se non oscuro) si è sentito più volte ripetere, soprattutto sui banchi di scuola, magari perché si apprezzassero maggiormente i furori civili di Dante, furori dai quali Petrarca si sarebbe liberato, distaccandosi così dalla politica attiva e militante, cui avrebbe preferito ora le corti ora la campagna, ora l’otium letterario ora la società dei dotti. Fu ingeneroso il Risorgimento letterario italiano verso il nostro grande Petrarca, come lo fu tutta la critica romantica, “colpevole” di averci offerto su un piatto pregiudizievole un Petrarca privo di quella coscienza dell’unità politica dell’Italia che l’amor di patria romantico esigeva .
Per qualcuno (De Sanctis) “la politica fu per il Petrarca non vocazione ma occasione”, per altri (Settembrini) le opere politiche del Petrarca sembrano piene “di cose che non sa, che non intende, e da cui è tanto lontano”. “Impolitico” lo definì sdegnosamente il Ferrari (sempre nel secondo Ottocento), perché non bastava la coscienza dell’unità geografico-storico-morale dell’Italia che il poeta possedeva, come appare inequivocabilmente da espressioni come, ad esempio, agnosco patriam rivolta al doge Andrea Dandolo nel momento in cui il cantore di Laura metteva piede a Venezia. Pure, era inequivocabile la sua italicità, intesa certamente come latinità, come romanità, quella romanità che si distende nella penisola che è giardino dell’Impero, che è viva nelle città e nei luoghi, figli di Roma: un patrimonio di civiltà che si respira nell’idioma, nei monumenti, nel sangue degli italiani, in nome dei quali Petrarca più volte invoca la pace tra le varie formazioni statali della penisola che scongiura, nelle sue lettere e nelle sue missioni diplomatiche, di non perdersi in lotte fratricide.
Può mai dirsi, dunque, impolitico un uomo che sempre si presentò come Italicus homo e che confessava di essere nihilo melior oeconomicus quam politicus, cioè uomo più politico che economico? O piuttosto deve dirsi uomo politico moderno e antico a un tempo, precursore di un’idea nuova della società politica e della politica stessa, cosmopolita, aperta al futuro eppure così fortemente legata all’idea della centralità di Roma di cui né lui, né l’Italia, né il mondo possono fare a meno?
Basterebbe il carteggio che Petrarca intrattenne con la corte imperiale di Praga, a cominciare dalla prima lettera all’imperatore Carlo IV di Boemia, poi posta ad apertura del X libro delle Familiari, a legittimare una professione politica che lascia ben poco spazio alla sfera dell’occasione e dell’effimero. In essa, cui altre sarebbero seguite, il poeta sollecitava Carlo a scendere nelle penisola senza indugio per restaurarvi la propria autorità. Le città italiane avevano atteso tante volte la discesa imperiale e sempre, dopo ogni discesa, si erano ritrovate in mezzo alle guerre, alla fame, alla peste. Forse la discesa di un imperatore era più da temersi che da augurarsi.
Eppure, il nostro poeta, per circa quindici anni, non si stancò mai di esortare l’erede di Cesare a compiere il suo dovere di “imperatore romano”. “Riportare nel mondo moderno –quello cioè dei tempi suoi- qualcosa che si ispirasse al modello della Roma augustea e al suo reale o presunto mecenatismo, fu in realtà dall’inizio alla fine della sua attività ed esperienza cultural-politica, il grande sogno del poeta”. Così, giustamente, scrive Ugo Dotti, attento studioso del Petrarca che ha curato per le edizioni Diabasis il ricco carteggio tra Petrarca e l’imperatore Carlo IV di Boemia, l’imperatrice Anna, i maggiori dignitari di corte, sia laici che ecclesiastici, tra i quali il cancelliere imperiale e l’arcivescovo di Praga.
Nel fitto carteggio, dal quale appare peraltro evidente la cupiditas gloriae del poeta, e la consapevolezza di essere riconosciuto “dominus et magister dall’intellighentija praghese, anch’essa desiderosa di dare vita al rinnovamento della cultura umanistica”, si legge come la politica del Petrarca è dovunque vi sia quell’humanitas, che, sorta all’insegna dei padri antichi, si fa virtù civile, dovunque vi sia quella virtù civile che si fa carta d’identità della società, sfera di urbanità, di pietas, di cultura.
Certo, non giovò a salvare l’Italia, giardino dell’Impero, neanche l’ultima exhortatio che il poeta rivolse all’imperatore con una lettera datata dicembre 1364. Quell’ Impero “per il quale Carlo era nato”, “quel vasto ed eccelso compito che la maestà dell’impero, armata di prudenza, giustizia e vigore non poteva non realizzare”, valsero ben poco alla politica italiana. Forse perché, suggerisce Dotti, lo stesso Petrarca, non esente da forti contraddizioni tra ciò che chiedeva appassionatamente a Carlo IV e ciò che era la presa di coscienza della reale situazione della politica italiana, era ben consapevole che “tutti i suoi sforzi erano in realtà fuori dalla storia”. Ma dunque, se così frammentata e contraddittoria era la situazione italiana, non si facciano di contraddizioni e incertezze del poeta quasi un caso patologico (cioè di squilibrio interiore del poeta) ma le si riferiscano alla legittima tensione del poeta che fu ora italiano ora europeo, ora repubblicano, ora amico dei principi, ma non certo impoliticus. Sempre, invece, testimone di un’etica in cui politica, humanitas ed economia convergono.
di Patrizia Danzè
Francesco Petrarca, Lettere all’imperatore, pp. 155, euro 23,a cura di Ugo Dotti. Diabasis, 2008
Redazione
(21/04/2015)
ViaCialdini è su www.facebook.com/viacialdini e su Twitter: @ViaCialdini












