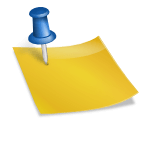L’Opera di Pechino diretta da Marco Plini e Xu Mengke al Teatro Argentina di Roma. Le vicende della glaciale principessa Turandot, la quale si sarebbe concessa in sposa a chi avesse risolto i suoi indovinelli pena la decapitazione.
di Viviana Raciti

Principessa Turandot al Teatro Argentina di Roma. Sincretismi di tradizioni. L’esotismo tanto in voga ai primi del Novecento, evidente in un’opera celebre come la Turandot di Giacomo Puccini, ha radici più antiche, basato com’era il libretto (controverso, a cura prima di Giuseppe Adami e Renato Simoni, e poi completato da Franco Alfano) su una vicenda semi mitica divenuta celebre nella favola di Carlo Gozzi, nella quale l’ambientazione orientale andava a braccetto con la volontà dell’autore settecentesco di contrapporre il fantastico al realismo goldoniano. Ma lo spartito (fatti salvi alcuni suoni che però intervengono più come abbellimento) dichiarava la propria provenienza occidentale; l’Est era, come per Gozzi, evocazione di un mito, di un immaginario, era insomma un fatto essenzialmente di parole: «Chi quel gong percuoterà / apparire la vedrà / bianca al pari della giada / fredda come quella spada / è la bella Turandot!».
Sul palco del Teatro Argentina Turandot ha ripreso appieno la propria anima orientale, intrecciando tradizione italiana con un genere distante, definito anche «quintessenza della nazione» cinese, “guó cuì”, l’Opera di Pechino. Il progetto, già forte di una prima collaborazione per il Faust goethiano, è una coproduzione internazionale tra China National Peking Opera Company, Emilia-Romagna Teatro Fondazione e Teatro Metastasio di Prato: due registi, Marco Plini e Xu Mengke; tre autori delle musiche, Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani e Qiu Xiaobo, strumenti moderni (un contrabbasso, una chitarra elettrica, percussioni) e corpo musicale della tradizione operistica cinese, si prestano a un riadattamento che lascia in ombra le musiche pucciniane, le celebri arie, per magnificare quella che è la natura altamente performativa dell’Opera del Sol Levante. Difatti, in questo genere (relativamente giovane, nato nel 1790 in seguito a una combinazione di stili artistici diversi, e comprendente un repertorio di più di 1400 spettacoli i cui argomenti, principalmente legati alla novellistica tradizionale, possono essere di tipo militare, amoroso, politico), il fuoco principale brucia nei corpi degli interpreti, che con leggerezza passano dal canto alle acrobazie, dalla stilizzazione delle arti marziali al mimo, magnificati da costumi e trucchi imponenti, i cui colori sono legati all’identificazione delle qualità del personaggio che li porta.
Le vicende della glaciale principessa Turandot, la quale si sarebbe concessa in sposa a chi avesse risolto i suoi indovinelli pena la decapitazione; quelle di Calaf, principe in miseria che osa sfidarla e vincere il suo essere “Principessa di morte”, e poi ancora le vicende del padre di lui, Timur, e della tragica fine della sua schiava fedele Liù, dei tre ciambellani e di tutta la coralità che abita l’opera, sono mantenute all’interno di una scena essenziale. Al di là dell’elemento classicistico evocato da imponenti colonne mobili, la cui presenza è più significativa nel ridisegnare ogni volta il campo d’azione, appare semplice la commistione tra le due tradizioni sceniche. Del resto, i personaggi gozziani si adattano bene alla struttura dei caratteri dell’opera cinese, in più di un caso avvicinabili ai nostri tipi della Commedia dell’Arte.

Un’introduzione vicina a noi, su xilofoni e contrabbasso, lascia velocemente il posto al suono caratteristico del gong, quasi a recuperare, attraverso la musica, quelle prime battute sopra citate: sembrano essere il viatico per entrare dentro un mondo totalmente altro, altamente codificato, in cui ogni elemento trova posto e valore ben definiti, immediatamente riconoscibili nel loro pubblico di provenienza, molto meno per questo.
Eppure, una volta abbandonata “l’ansia da libretto”, tranquillizzati anche dai tre monitor per i sottotitoli, gli sguardi si concentrano sui movimenti dei performer, sui loro corpi costantemente in disequilibrio, nella tensione del singolo gesto, della stizzita voltata di spalle della principessa vendicatrice; della mano che trattiene la lunga manica per imprimere forza opposta al braccio, della lotta di gambe e braccia in cui il corpo risuona “a distanza”, senza che effettivamente venga inflitto il colpo. Ci si lascia condurre nell’accordo perfetto dei movimenti con la musica, movimenti la cui leggiadria è frutto di un training durissimo che impone un grado di difficoltà maggiore rispetto al gesto poi portato sulla scena.
Mei Lanfang, attore e fondatore nel 1955 della Compagnia, raccontava questa modalità di recitazione come una volontà e una pratica ferrea che imponessero all’interprete di dimenticarsi di sé per lasciar posto al “Personaggio”, ché solo quello doveva essere mostrato. L’altissimo grado di convenzione di questi caratteri, le loro voci impostate forse cedono a una piccola trasformazione in scena: la voce acuta di Turandot, dopo che ella si è lasciata rapire dalla passione per Calaf e ha fatto prevalere ancora l’orgoglio sull’amore portando al suicidio la serva Liù pur di non velarne il nome, cambia registro; la principessa si pente, scende di un tono e il falsetto diventa voce rotta, di pancia, tocca altre corde, genera altri sguardi, imposizione diventa amore, la favola è giunta alla fine. ( https://www.teatroecritica.net )
Teatro Argentina, Roma – febbraio 2019
TURANDOT, drammaturgia Wu Jiang e Wu Yuejia
Regia e scene Marco Plini,
Musiche originali Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani e Qiu Xiaobo
Regia per l’Opera di Pechino Xu Mengke
Con gli attori della Compagnia Nazionale dell’Opera di Pechino : Xu Mengke – Calaf, Zhang Jiachun – Turandot, Liu Dake – Timur, Wu Tong – Liu Ma Lei – Wang Ping, Wang Chao – Ping, Nan Zikang – Pong, Wei Pengyu – Pang
di Viviana Raciti
(07/03/2019)
ViaCialdini è su www.facebook.com/viacialdini e su Twitter: @ViaCialdini